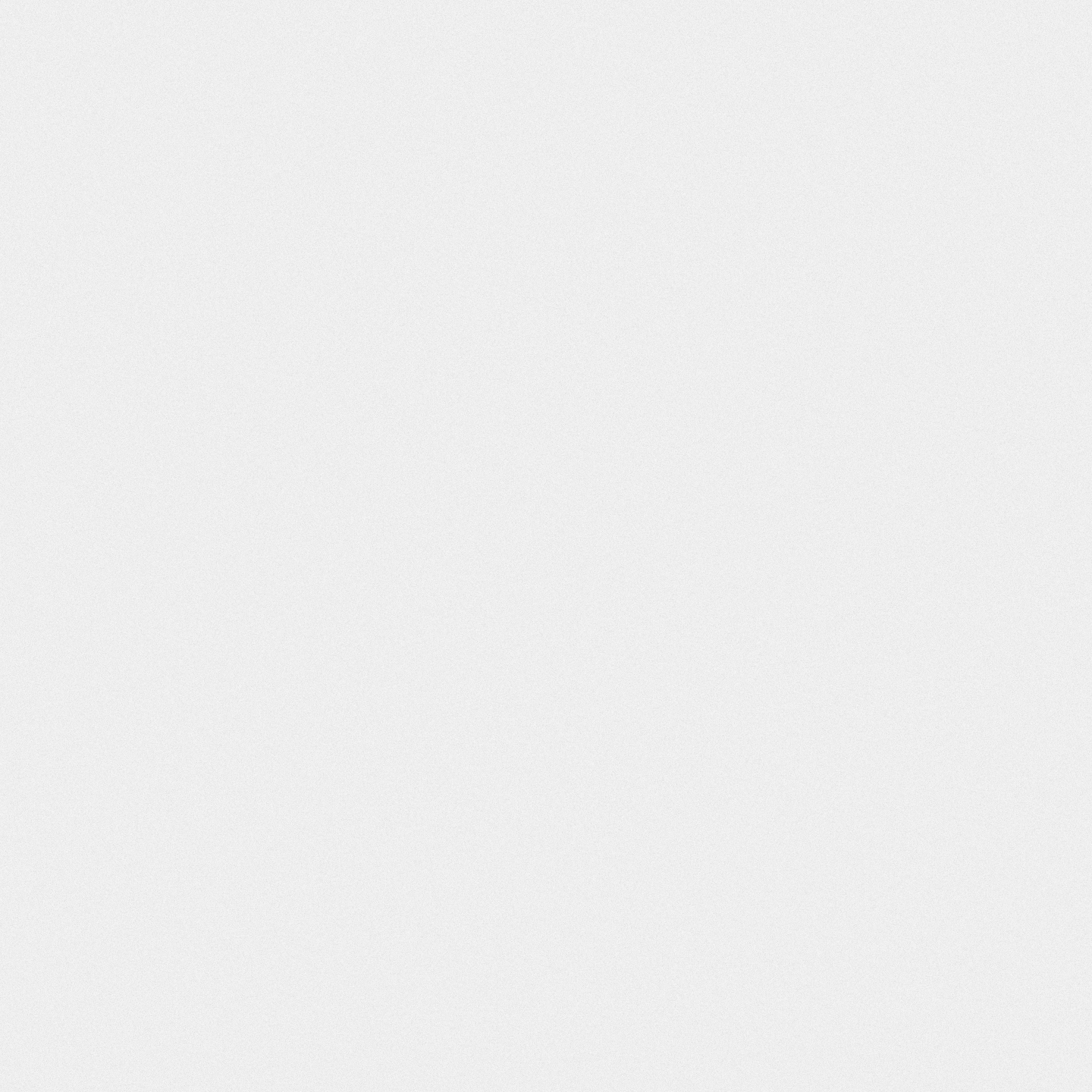

Cautano
Terra di Briganti
Il Taburno, rifugio perfetto
Il monte Taburno, per la sua toponomastica fortemente caratterizzata da grotte, ha rappresentato in quest'epoca storica l'ideale rifugio per tutti i briganti del circondario Beneventano e non solo. In questo scenario ambientale è possibile ricostruire, più che sommariamente, i modi attraverso i quali i briganti riuscivano a vivere ed a far fronte alle varie necessità; sembra inoltre che nel tempo siano stati trovati segni evidentidi un vissuto quotidiano; cibi, vino, fucili, fiori curativi, sacchi di sale per cicatrizzare le ferite, fasce, bottiglie con acqua santa per benedire i moribondi e cose affini. I briganti, erano appogiati dagli abitanti dei paesi limitrofi alle zone della montagna in cui vivevano, ed in altri casi minacciavano uomini più o meno possidenti di scendere in paese e fare razzie di tutto nel caso in cui non venissero ben rifocillati; è dunque attraverso fitte reti di cooperazione anche forzata a volte che questi combattenti riuscivano a procacciarsi da vivere.
Cautano e i legami con il Brigantaggio
Nel XIX sec. Cautano fu uno dei più importanti centri del brigantaggio del Sannio, qui infatti era dislocato il quartiere generale del capo-brigante Martino Luciano, uno dei più sangiunosi briganti che la storia del meridione abbia avuto.
L'adesione morale e onesta di Martino Luciano alla causa brigatista naque da una fedeltà al suo Re borbonico nata e cresciuta attraverso i racconti del Conte Ottavio Procaccini, feudatario di Cautano, Suo paese Natale.
Tra la fine del '60 e l'inizio del '61 venne istruito dagli ufficili decorati al valore del '48-'49, alla guerra di logoramento, questi ufficiali furono inviati da Francesco Borbone con l'incarico di costituire i ruoli dirigenti della guerriglia partigiana e trovarono in Martino un esemplare elemento. L'8 Dicembre 1861 il Conte Procaccini fu arrestato per aver svolto opera di proselitismo e Luciano con i fratelli Luigi e Mattia, giurando di combattere fino alla morte per Francesco II; non venendo mai meno a questa promessa.
Pur non esistendo né una biografia ne una omogeneità di notizie a riguardo della vita di Martino, una profonda analisi comparativa di vari testi e documenti mi portano ad affermare che costui in un primo momento deve essersi allontanato dall’area cautanese, in quanto facente parte di un fittissimo reticolo operativo di gruppi di briganti, all’interno del quale Martino rappresentava si, l’anello impegnato nell’area più prossima alla montagna del Taburno rispetto alle altre, ma in una geografia che guardava da Camposauro al versante Molisano del Matese. Risulta infatti che nella primavera del 1862 Luciano Martino vegliasse l’area tra Solopaca e Casalduni, Michele Caruso si accingesse ad invadere il Morconese e Nunzio Di Paolo era invece impegnato tra il Matese e Campobasso.
Dò queste tre indicazioni come ausilio per concepire visivamente la zona, per l’appunto in direzione del Matese, verso la quale anche Martino operò, ed il 28 Marzo 1862 diede anche avvio alla sua serie di sequestri politici. Sappiamo inoltre, che nonostante il grande vantaggio dei briganti sulle Guardie Nazionali soprattutto per la praticità nei confronti di tali territori, è proprio in questo frangente temporale che alcune bande furono annientate ed altre si spostarono verso lo Stato pontificio, e che questo, ma soprattutto l’approssimarsi dell’inverno, portarono ad un momento di sosta del brigantaggio che però nel 1863 divampò nuovamente e vide sul Matese per qualche mese, Luciano Martino tra i protagonisti.
Ad avallare la tesi per la quale Martino abbia operato a Casalduni abbiamo una testimonianza di Cipriano La Gala che ai giudici della corte di Assise di S. Maria Capua Vetere riferì finanche che il brigante fosse nativo di Casalduni pur essendo questa una informazione errata. Sappiamo infatti per certo che pur avendo partecipato attivamente alla gestione della zona di Casalduni, e a dare credito a questa tesi c’è anche la notizia che il medico curante di Luciano Martino fosse il Dott. De Blasio Bonifacio Di Cesare residente a S. Lupo, Comune confinante con Casalduni, Luciano Martino sia stato nativo di Cautano.
Il 18 Marzo 1863 Martino rientrò nelle sue zone insieme alle bande Giordano e De Lellis e si trasferì alle pendici di Camposauro nell’area del vitulanese e del bosco di S. Stefano con i suoi 30 uomini. Martino insieme a Cosimo Giordano, il quale si ferma in località Sette Serre, al di sopra di Tocco Caudio, ideano piani, stabiliscono turni di guardia, decidono di dare avvio ai sequestri di sera di nascondersi nei boschi attigui alle Sette Serre durante le perlustrazioni e di fare dormire gli uomini nei valloni dove è più difficile essere scoperti. Luciano pur avendo la stessa influenza di Cosimo tra i guerriglieri fu diversamente considerato rispetto a quest’ultimo dalle autorità, rivestendo ai loro occhi maggiori responsabilità; Luciano aveva infatti una spiccata bravura logistica e capacità di avvalersi della fitta rete di Manutengoli costituita dai carbonai di Vitulano e i pastori di Cautano.
Lo stesso comandante militare della zona si era infatti rassegnato ad attendere momenti più propizi per la sua cattura, in quanto sempre sfuggito nelle normali “cacce ai briganti”. Il 28 febbraio1863 il sacerdote Don Antonio Pigna di Guardia Sanframondi riuscì a fuggire dal rifugio dei briganti dai quali fu sequestrato e tenuto prigioniero per circa 13 giorni sulle montagne di Cautano e Cacciano insieme al notaio Antonio Rinaldi, dopo la sua fuga, diede prova di come circolassero nei loro rifugi viveri di ogni tipo, le cose più buone e soddisfacenti, senza rinuncia alcuna, portati di continuo dai manutengoli. Questi, erano di giorno i legnaioli e carbonai di Vitulano, Cacciano e Cautano, di notte, donne che si inoltravano tra i rifugi e spesso restavano per diverse ore presso loro.
Don Antonio raccontò poi dell’incontro avuto con il capo-brigante Luciano ed il fratello Luigi Martino, un giorno in cui il sacerdote sentitosi male chiese aiuto, il primo si avvicinò somministrandogli una dose di sale inglese ed il secondo, gli portò subito un caffè preparato da lui stesso. La sua fuga fu notturna, riuscì, con una scusa ad allontanarsi anzitutto da Rinaldi, per poi approfittare della disattenzione della sentinella per fuggire e raggiungere presso Vitulano la casa di un suo parente, Rivellini, dalla quale casa scrisse una lettera a suo fratello capitano della G.N. spiegandogli l’accaduto. In quanto al Rinaldi sappiamo che il 13 Marzo dello stesso anno venne rilasciato dai briganti dopo aver gridato: -Viva Francesco II! Viva Pio IX! Viva il generale Cosimo Giordano!- .
Ad accadimenti simili è ancora fortemente legata la tradizione orale che alimenta una sempre viva memoria collettiva; a questo proposito una testimonianza ancora viva è quella riguardo il rapimento del sig. Giovanni Procaccini, al quale fu mozzato un orecchio recapitato ai familiari per sollecitare il pagamento del riscatto. Liberato, Giovanni Procaccini morì poco dopo di arresto cardiaco.
Luciano, non era solo molto temuto dai militari, egli suscitò sentimenti negativi anche tra quei briganti che non erano evidentemente fedeli alla propria causa e che se avessero potuto, lo avrebbero venduto al potere. Questo, accadde il 19 aprile 1863, quando Giovanni Sciascia detto Pecchia di Frasso per intascare il premio, ossia una notevole somma di denaro, fa sapere che Luciano con la sua banda ha trovato ricovero nella masseria di Geremia Viglione a Cacciano. Da Cautano e Foglianise accorsero le truppe militari e, dopo 4 ore di fuoco il colonnello che comandava l’operazione ordinò di incendiare la cascina, i briganti allora si lanciarono dalle finestre, tra questi, 22 riuscirono a fuggire 8 furono uccisi: Giovanni Nocerino di Solopaca, Giuseppe Cofrancesco di Cerreto, Donato De Nisi di Castelpoto, Vincenzo Venditto e un tale Salvatore di Caserta, Nunzio di Benevento, Mariaccio di Pomigliano d’Arco, Giovanni Ferrazza di Piedimonte d’Alife domanda la vita, fatto prigioniero, fu fucilato il giorno dopo ed anche Luigi Martino, fratello di Luciano; il quale nato il 16 settembre 1838 morì quello stesso giorno a poco più di 24 anni.
Luciano consumò la sua vendetta incaricando Brillo Clemente alias Sproppa di uccidere Pecchia, l’esecuzione ebbe luogo nel sito crocevia in contrada piana di Prata il 20 ottobre 1863 e lo stesso Martino precedentemente trasferitosi presso Pozzillo e piana di Cepino sul Taburno passò poi in località Petrosola in tenimento di Frasso dove si unì alla banda del capobrigante Andrea Miseria. Qui prima di procedere ai sequestri si orientò tra i potenziali complici che trovò in Nicola Meoli sottotenente della G.N di Apollosa, il quale lo avvisava dei movimenti delle truppe e gli dava informazioni sulle persone da catturare e Cosimo Gisonti, Sindaco di Frasso, che permise ad una tale Colella di panificare di nascosto per loro e ai vari manutengoli di accedere sotto falso nome alla montagna di Montevergine. Sul finire dello stesso anno però Andrea Miseria in pericolo di vita scappò a Roma, per rifugiarsi presso Cosimo Giordano, che, risulta essere arrivato nello Stato Pontificio già alla data dell’esecuzione di Sproppa. Anche Martino aveva ricevuto la stessa possibilità di asilo, ma la fedeltà al suo popolo e alla sua donna Maria Masciotta, da cui aveva da poco avuto un figlio, gli impedirono di accettare. Continuò la sua impervia impresa sparpagliando i suoi uomini attraverso la piana di Prata, il vallone dei Ruttuni, nel luogo del passaggio che dalle sette serre verte alla Montagna del Taburno e il bosco dell’Abbadia di Solopaca; suo fratello Mattia continuamente al suo seguito, raggiunge diverse volte contrada Guglieta di Pontelandolfo, dove, incontra Maddalena Ciarlo, sua amante, ma la spia Francesco Antonio Calabrese detto Crocco per una ricompensa di £. 200, dopo averli scovati segnala il nascondiglio alla G.N. ed il 16 agosto 1864 la masseria è circondata. Mattia combatte da solo contro 3 ufficiali e 30 militi comandati dal Maggiore della G.N. Filippo Iadonisio e, già cadavere massacrato dai colpi di fucile, è preso a colpi di pietre.
Luciano, che aveva perso entrambe i fratelli che lo affiancarono fino alla morte, cosciente di non potersi fidare di nessun altro e continuamente braccato dalle truppe continuò a combattere con i suoi fedeli gregari Francesco Marcarelli, Giuseppe Masone, Francesco Caporaso e Francesco Izzo, finchè arrestato fu ucciso ai primi di Agosto 1865, fucilato dai bersaglieri del Generale Cialdini nella piazza di Cautano.
Furono in oltre catturati e condannati perché colti sul fatto, quali somministratori di viveri,notizie e ricovero a Luciano Martino: i fratelli Angiolella Domenico e Giuseppe di Foglianise, Buono Francesco guardaboschi di Vitulano, Orlacchio Salvatore di Cautano a 20 anni, Angiolella Luigi a 15, Papa Giuseppe di Tocco Caudio e Marcarelli Maria Michela di Cautano a 10 anni di reclusione, molti altri morirono. La stessa Maria Masciotta, donna di Martino fu deferita al tribunale militare di Caserta nel settembre dello stesso anno.
FONTI
-
Luisa Sangiuolo, “Il brigantaggio nella Provincia di Benevento 1860-1880” Azioni di brigantaggio ai confini con Terra di Lavoro e nelle Valle Telesina. Ed. De Martino, Benevento, 1975.
-
Vincenzo Mazzacca, Repubblica Partenopea e brigantaggio. Un prete e un notaio sequestrati dai briganti, (p. 142) Ed. Gennaro Ricolo Benevento.
-
Queste informazioni si rilevano anche in Vincenzi Mazzacca, “Mura e Sentieri”. Rapporti del Governatore di Benevento Gallarini sul brigantaggio, Trimestre: Agosto-Ottobre 1861, Ed. A.G.M. – Beltiglio di Ceppaloni (BN) – 1994.
-
Luigia Lanzetti, "Cautano viaggionel tempo e nei ricordi" il brigantaggio. Ed. Borrelli srl, San Giorgio del Sannio (BN), 2009.




